di Mariateresa Pazienza
Tutti hanno uno o più scrittori preferiti. Conosco qualcuno che non si da pace se non dopo aver letto tutte le opere di un autore. Diventa quasi un’ossessione. Passi ore intere a leggere cose di e su di lui e non importa quanto sia stato prolisso, (o prolifico, fa lo stesso) ciò che conta è arrivare alla fine della sua bibliografia. Personalmente sono una lettrice molto selettiva. Non divoro libri come se non ci fosse un domani. Doso accuratamente le quantità di parole da somministrare alla mia mente e ai miei occhi. Questo è un aspetto che mi ha fatto scoprire la grandezza del dire molto con poco. E in questo caso non potrei che citare Carver come la sorpresa di questa mia ultima filosofia di lettura.
Ma non è Raymond Carver la mia punta di diamante, nonostante la prosa sempre lineare e asciutta. Ho anch’io una scrittrice preferita, ed è Agota Kristof, l’apolide ungherese famosa soprattutto per la splendida Trilogia della città di K. e Ieri, romanzi pubblicati tra l’86 e il ’95. Nell’opera di Agota Kristof però ci sono altri titoli che meriterebbero la stessa attenzione dei suoi scritti più celebri.

A ogni suo libro è legato un aneddoto della mia vita. Oltre ai due libri già citati, è grazie a L’analfabeta (Casagrande, traduzione di Letizia Bolzani) che ho conosciuto la storia di Agota Kristof. Questo breve racconto autobiografico diviso in undici scene (tableaux nella versione originale) ripercorre i passaggi più importanti della vita della scrittrice ungherese. Quello che emerge maggiormente da L’analfabeta è l’aspetto sociale e linguistico affrontato da Agota una volta arrivata in Svizzera dopo la Rivoluzione ungherese del ’56.
La difficoltà incontrata a causa della lingua da Agota, che sapeva leggere dall’età di quattro anni, era riscontrabile in quel senso di inadeguatezza per il ritrovato analfabetismo. Quando parla della lingua materna, messa in contrasto con le cosiddette lingue nemiche, Agota Kristof racconta anche un pezzo di storia contemporanea. La vita in un villaggio in cui un quarto della popolazione parlava tedesco, l’obbligatorietà dell’istituzione del russo come lingua ufficiale per tutti gli stati satelliti dell’Unione Sovietica e infine il necessario e non voluto ingresso in Svizzera in seguito alla rivoluzione, tutti questi avvenimenti permettono ad Agota di elaborare la sua personale filosofia riguardo le lingue che hanno portato alla morte la sua lingua materna.
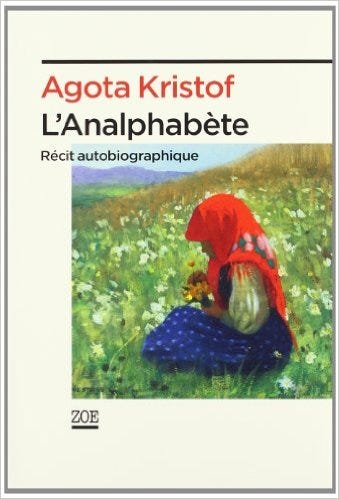
E’ un po’ come quando si trascorre un periodo all’estero. L’immersione totale nella lingua di un altro paese è tanto un arricchimento culturale quanto un fattore di rischio. Quando non si conversa più nella propria lingua materna, pare che si tenda a dimenticare certi meccanismi presenti in essa, con buona pace di Chomsky & co.
Quando si parla una lingua straniera per necessità — penso ai rifugiati che scappano da un paese martoriato dalla guerra -, è inevitabile percepire questa seconda lingua come qualcosa di estraneo, accessorio, o peggio, nemico. Nel nono capitolo Agota è arrivata da poco a Neuchatel, il bel paese da sempre simbolo di tranquillità, che a lei non ricorda altro che un arido deserto. E allora quando ne ha la possibilità cerca di dormire un po’ di più per poter sognare il suo paese d’origine che col passare del tempo diventa sempre più un ricordo sbiadito. Oltre ai consigli su come diventare scrittori (scrivi, anche quando credi non interessi a nessuno), L’analfabeta riporta con la più schietta sincerità gli avvenimenti migliori e peggiori accaduti nella vita di una scrittrice. Nell’analfabetismo incontrato dopo la fuga dall’Ungheria Agota Kristof ha trovato un motivo per sfidare sé stessa, quella sfida che lei stessa attribuisce all’analfabeta protagonista del racconto.
