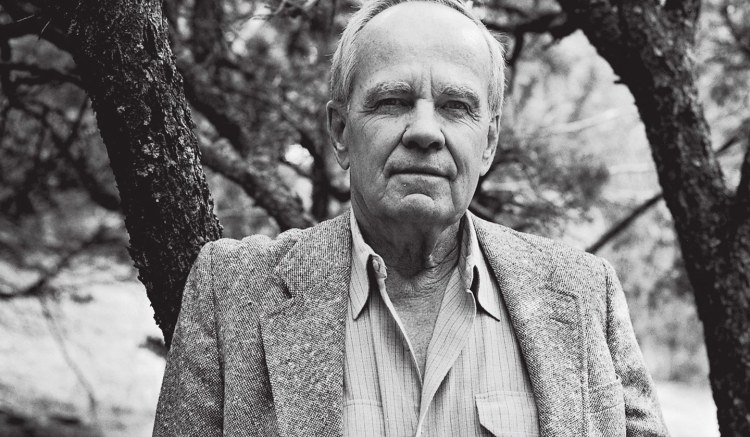«I dormienti dormivano. La periferia triste e mal illuminata di una città sfilò davanti ai vetri. Steccati, appezzamenti coperti di erbacce, sterili campi autunnali scorrevano spenti sotto le stelle»
McCarthy è uno scrittore solitario, scarse apparizioni in pubblico, rarissime interviste. Chissà che effetto fa starsene da qualche parte senza curarsi di quello che dicono di te degli anonimi che da lontano ti “venerano”. Qualcuno ha detto che è uno scrittore per uomini perché nei suoi romanzi mancano i protagonisti femminili o se ci sono rivestono un ruolo secondario, marginale, di sfondo. Non la reputo una verità assoluta, questa. Se è vero che in molti dei suoi romanzi – come La Strada, Non è un paese per vecchi e Suttree, per citarne solo alcuni – i protagonisti appartengono alla categoria maschile, è anche vero che il gentil sesso non è assente in toto. I suoi personaggi sono “uomini”, ma non in quanto semplicisticamente soggetti maschili. La sua non è affatto misoginia, ma la risultante di un progetto definito che si propone di raccontare storie universali, narrare le vite di esseri umani. Suttree è uno di questi: umile pescatore senza un soldo, un ex galeotto che quando è fortunato pesca pesci gatto nel denso corso d’acqua che lambisce le rive di Knoxville; la sua figura ha lo stesso portato soverchiante di un filosofo del Novecento, la medesima aura consacrata di un profeta. Difficile non amarlo e difficile da dimenticare il poderoso insegnamento che trapela dai suoi lucidi pensieri.
A volte non basta leggere, certe volte è necessario uno sforzo maggiore: bisogna immergersi nelle immagini d’inchiostro per poi riemergere come persone nuove. McCarthy ha questo potere e il Tennessee degli anni ’50 che racconta vividamente ha la forza soverchiante di portarsi addosso le incoerenze di un continente, l’America sud-orientale, la quale riveste il ruolo catartico di una rivelazione fatta da uno sciamano, distante e trasognato. Il fiume che irriga la città di Knoxville assurge ai livelli del Gange, mistico corso d’acqua di salvezza attanagliato negli argini di un mondo d’eccessi. Suttree è emblema di tali esuberanze ma anche elemento equilibrante, una specie di pastore che governa le greggi nelle praterie americane e che nelle vesti di Buddy (per gli amici), è l’uomo che si lascia agire tra le irrequietezze e i fiumi d’alcol di una sfrontata e tangibile America. È il pacificatore, ma anche l’attaccabrighe, quello che non beve mai, ma che spesso troviamo ubriaco, quello che non ha colpe, ma che va in galera. L’innocente e il peccatore nel lacerato mondo di una nazione di scissioni e insensatezze. Un paradosso, un’incoerenza umana, uno dei personaggi più belli della letteratura contemporanea che risulta difficile non amare. In quest’opera più che in altre, McCarthy abbonda nelle descrizioni del paesaggio, restituendo al lettore un contesto definito non solo nei dettagli geografici ma anche nelle atmosfere, con immagini di tangibile bellezza e delicata rarità; in questo modo si presentificano visioni lucide e disarmanti che inghiottono l’anima di chi legge, ne adottano lo spirito e la materia.
L’universo fluviale nell’impeccabile e ricco vocabolario descrittivo – che non risparmia nemmeno tecnicismi presi in prestito dal linguaggio navale e da quello botanico – si conforma alla splendida capacità di costruire storie, intessere insieme le trame di esistenze e impostare una solida impalcatura del racconto costituita da un bilanciamento attento e una commistione distaccata delle vicende differenti dei protagonisti. Ogni componente è valida per se stessa, ma qualunque frammento è parte del tutto, ciascun elemento pur essendo al suo posto, dialoga con il resto.
«Qualche albero annerito avvizziva nella calura e in quell’oscuro purgatorio un tordo cantava. Un tordo sassello. Turdus Musicus. Uccello lirico dei miei coglioni»
Eleganza ed estro poetici, calibrati da una destabilizzante ironia finale: in questo risiede la grandezza del saper scrivere grandi storie in un modo non banale, ma soprattutto – nel suddetto caso – dell’aggiungere determinati particolari non necessari, facendo di essi e dello specifico modo in cui si raccontano, poesia. Il demiurgo è colui che plasma la materia, un qualche essere immortale ma anche mortale che modella un blocco d’argilla. Solo una possibilista manifestazione, questa: il demiurgo può essere un fabbro che batte il ferro sull’incudine con un grosso martello, lo scultore che modella il marmo o la creta, oppure lo scrittore. Tra i miei esempi di demiurghi in questo senso, vi è McCarthy. Il suo stile ironico ma anche fortemente nostalgico, trasognato ma nello stesso tempo impregnato nella realtà più nitida e vera – intensamente raccontata senza troppi fronzoli e con compostezza acuta e dettagliata – ci permette, girovagando a piedi nella città notturna, di fare stranianti e bellissimi incontri, come quando sotto le luci dei lampioni nelle strade umide e deserte «un piccolo pesce tropicale guizza e si arresta negli abissi verde muschio della vetrina dell’oculista».
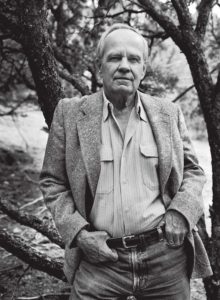
Photograph by Kurt Markus
«Sul fondo remoto dei suoi occhi piangenti si rincorrevano le foglie morte»
Siamo nel periodo autunnale e il nostro eroe, dalla baracca sul fiume torna a casa per una luttuosa circostanza, la morte del figlio. Ma viene cacciato e per poco ammazzato, colpevole di aver, in precedenza, abbandonato il letto coniugale. Allora fugge tra i campi, fa l’autostop e se ne fa una ragione. Le regole del gioco sono state smistate e hanno subito una lieve variazione: lirica e narrativa si fondono e confondono costantemente nell’opus magnum dell’americano. Non stupisce un fatto del genere, Cormac è poeta prima di essere abile costruttore di impalcature di esistenze. L’afflato poetico smista nefandezze e discerne la luce dalle tenebre, operando un denso equilibrio tra le due parti e conservando l’essenziale che ripropone sotto forma di letteratura debitrice della poesia in un condensato di ineguagliabile capacità narrativa. Non inserisce elementi poetici casualmente, ma li impianta nei punti che il lettore qualificherebbe come meno possibili: sono delle sorprese, che fanno comprendere il calibro della penna di McCarthy, meravigliosi e improvvisi doni, ponderate fatalità.
L’universo interstellare nel quale agiscono i tormentati personaggi di McCarthy è qualcosa che – adottando un’espressione della filosofia del vecchio continente – potrebbe essere espressa come «umano, troppo umano». Si sente l’odore dell’America centrale e si intuisce l’indole degli abitanti del Tennessee, stato acquoso di fertili pianure e città polverose. Gli anni ’50 a Knoxville – ma in generale i ’50 e i ’60 per Stati Uniti, Europa e Giappone – furono un periodo di fermento, un momento di grande sviluppo economico, quella che è meglio conosciuta come «“l’età dell’oro” del capitalismo industriale» – quando «le mosche fendevano l’aria come comete» e Suttree continuava a collezionare indecenti sbronze che lo conducevano a strane situazioni che prendevano la parvenza di sogni, ma erano realtà, e allora si trovava a vedere sprofondare ordinarie verità che un tempo conosceva: in questi casi affiorano descrizioni di alto valore e di significato intenso: «da qualche parte sotto di lui vagavano i suoi piedi».
Cormac McCarthy non è in genere uno scrittore che va spesso a sondare elementi del sapere extrasensoriale; è certo spirituale, escatologico, sacralizzante, ma di norma resta ancorato alla realtà, allo spirituale quotidiano, nel suo pragmatico materialismo. Succede però, che in un certo momento, per la precisione alla pagina 330 nel caso di Suttree – quando Harrogate, il maldestro amico del protagonista che dopo una serie di fatti scellerati che l’hanno condotto in trappola dentro una caverna fetida, un argilloso e inaccessibile antro, dove è rimasto intrappolato per giorni fino a quando non viene salvato proprio da Suttree, rivela al protagonista qualcosa di assurdo e patetico agli occhi di quest’ultimo, dicendo: «C’era gente quaggiù. […] Ci ho parlato» – va mutando prendendo sempre più i caratteri dell’allucinatorio, un allucinatorio che comunque non sovrasta una narrazione che resta sempre ancorata al reale, alla concretezza della vita manifesta.
Si fanno strada, comunque, misterici presagi sinistri, come una “vecchia strega” che terrorizza il protagonista con l’abbozzo di una veggenza non rivelata, fatta solo intuire, tracciata con vaghe parole nell’aria pesante di una baracca isolata nel bosco d’estate. La stessa percezione allucinata è riproposta quando Suttree, nel mezzo di una foresta che si accinge a morire nel gelido inverno, sopraffatto dalla mancanza di forze, comincia ad essere affetto da visioni abbagliate, nel suo aberrante vagabondaggio, che diviene presto sosta, riposto, miraggio.
«La foresta era pervasa da una luce strana.»
«Cominciava ad avere dei compagni di viaggio. Dapprima gli erano apparsi in sogno e poi negli stati di semiveglia. […] Passarono due giorni neanche e non capiva più bene se sognava o era sveglio.»
«Tutto gli era caduto di dosso. […] briosa vertigine momentanea, illusione di essere sbalzato nello spazio azzurro e ventoso, nel fuorigioco del mondo, a precipizio tra gli esili cirri lassú.»
Riguardo alla sensazione particolare che segue l’entrata nel testo di elementi di ordine non materiale, emblemi aleatori di un mondo al di là del visibile, un segno di un certo tipo di inclusione tra le pagine di quello che McCarthy chiama «una fottuta proiezione mentale», è evidente anche da un particolare interessante: la prima persona. Mai nel testo prima di pagina 347 si verifica uno straniamento del genere, il romanzo è tutto scritto in terza persona, ma in un dato momento, come fosse anche lui frutto di una chimera, emblema, artefice e vittima della follia del protagonista, Cormac McCarthy interviene e scrive: «E finalmente approdò in una piccola radura e cadde in ginocchio senza fiato. Nubi remote e immobili striavano il cielo serale come latte di pesce sulla superficie di qualche laguna costiera del pianeta e una beccaccia bianca si alzò in volo dalle felci davanti a lui e svanì nel fumo. Un gomitolo di piume si cullò in quella luce verde per il bene della mia sanità mentale. Uccello irreale e silenzioso albato tra il sole e l’addio della mia mente guasta».
La mia sanità mentale, la mia mente guasta.
Il passaggio dalla terza persona singolare alla prima è improvviso e soverchiante, si presenta come magia, segnale fatato coerente al contesto incantato, dove gli equilibri ormai scardinati del loro armonico funzionamento permettono un’eccezione del genere, anzi forse la impongono per caricare l’atmosfera di un afflato ancora più straniante e straordinario. Questo passo è importante perché l’intervento dell’autore non solo garantisce in qualche modo l’autenticità di ciò che è successo in precedenza, ma permette anche di ristabilire gli equilibri, di bilanciare la storia e riportare il personaggio su quella che era la sua strada: una presa di coscienza di ciò che è stato ma anche una cesura per mettere fine a quello squilibrio nefasto che avrebbe condotto non solo il protagonista, ma anche lo scrittore alla follia. È un intervento, questo, di elevata capacità tecnica che si inserisce nel grande panorama della tragedia greca inaugurata da Euripide; quello che è stato definito il “distruttore della tragedia” introdusse l’espediente del deus ex machina, che consisteva nell’intervento a sorpresa di una qualche divinità, garante di un ordine sacro e precostruito, per sistemare i disordini interni dai quali i personaggi non sarebbero stati in grado di uscire da soli.
Ristabilire i conti, trarre le somme, mettere ordine al caos. In seguito si verificano altre situazioni destabilizzanti che stravolgono l’ordine delle cose, circostanze assurde in contesti veritieri che si rivelano fasulli, eppure tutto è narrato tanto vividamente che il lettore non solo se ne immerge languidamente ma ne viene sommerso e non fa un passo per spostarsi.
Ammalia come un alchemico filtro portentoso, una pozione intrisa di chissà quali magie. È una scrittura capace di rendere vivido il mondo che si vede, ma anche quello che si intuisce solamente, parole che scardinano e frantumano la lastra fragile e ingannevole dell’ordinario. È un brontolino in cui navighiamo, il fondo melmoso e roboante dei meandri più profondi della nostra psiche.
Alla fine rimangono poche cose distillate dall’amalgama ingarbugliata di pensieri, resta, per dirla con McCarthy, qualche «pazzo dichiarato» che se ne sta seduto immobile in un manicomio dimenticato «salmodiando tra sé qualche dossologia silenziosa».
© Iole Cianciosi