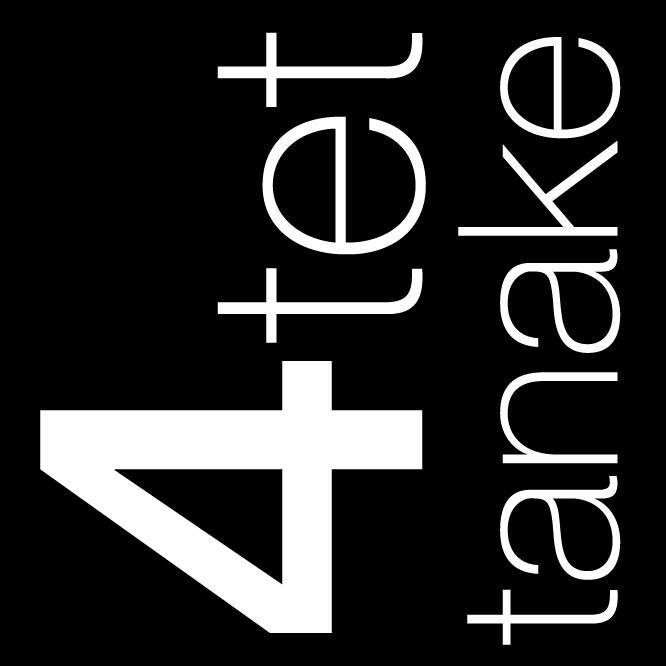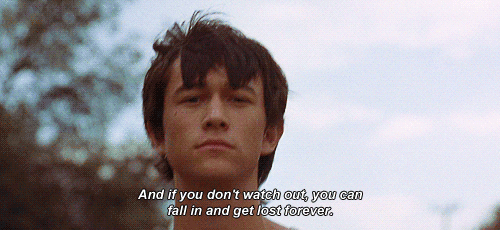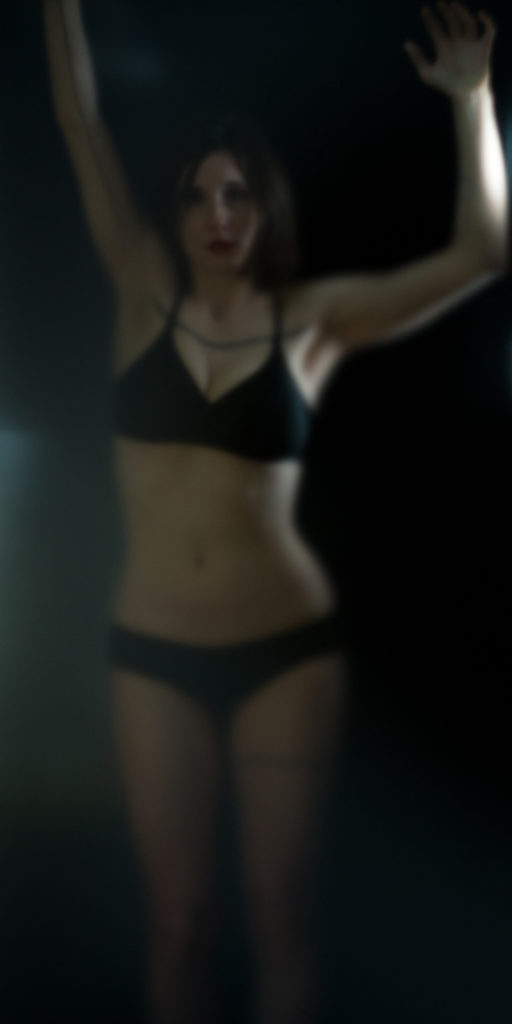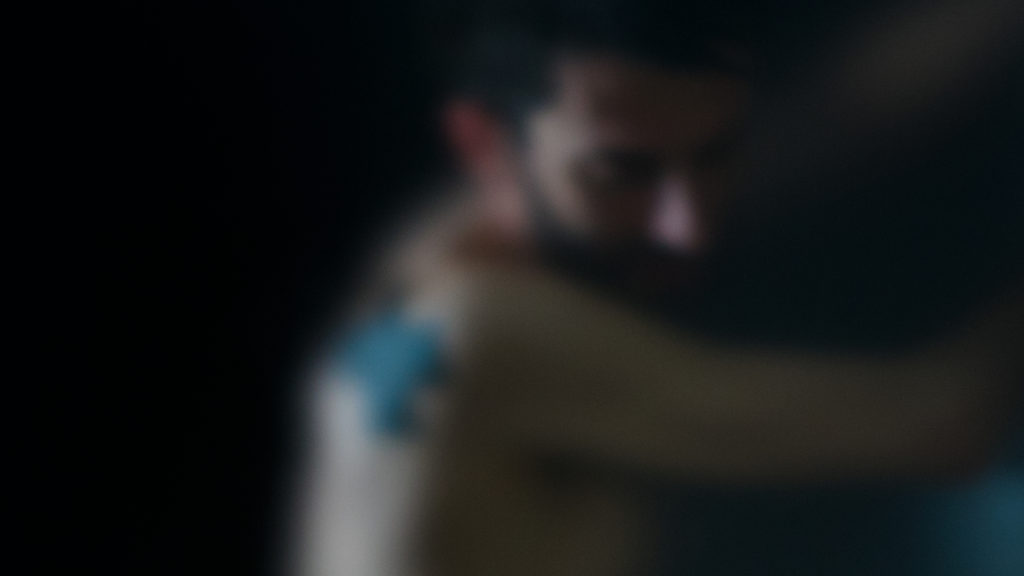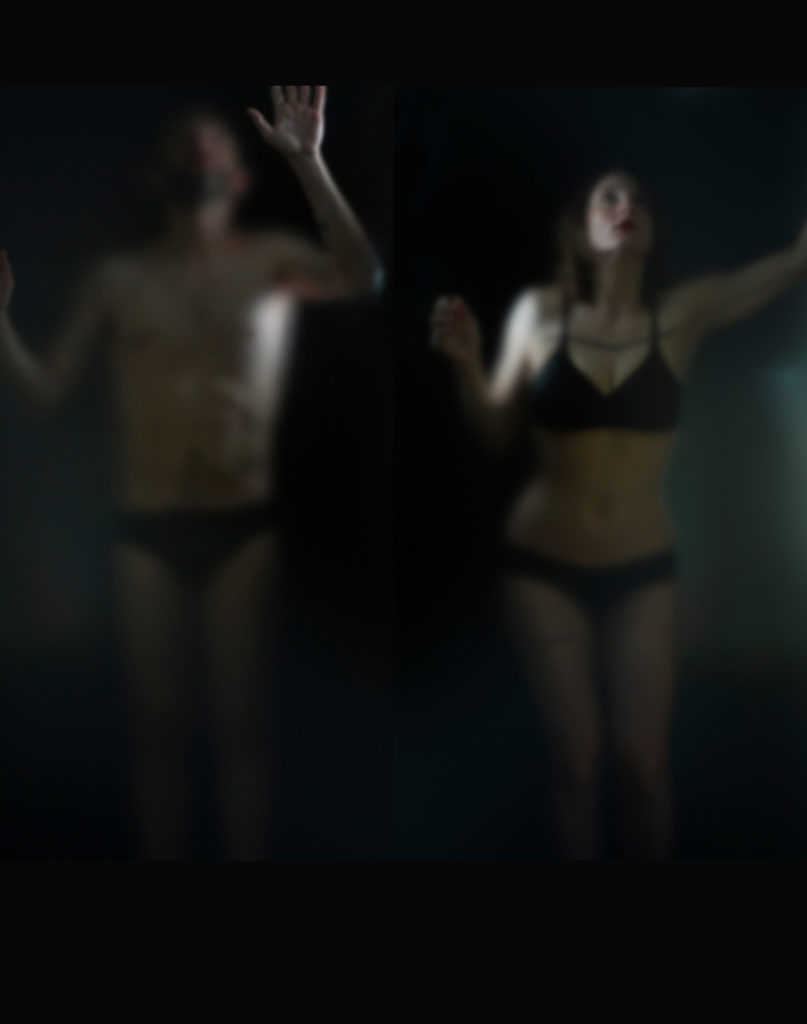—
Perché dovrei parlare con te? Dimmi.
Non sapevo neppure esistessi fino ad un attimo fa ed è mezzo minuto che ti dico di andare.
E, sai, mi prude il naso. Proprio adesso. E devo scegliere se grattarmi o parlare. Se stare in me o non stare affatto.
E poi è morta Mary Ann, li dove è nata, a Macungie, Pennsylvania.
L’ho conosciuta un anno fa che aveva già 93 anni, e l’ho fotografata mentre le visitavano gli occhi.
Aveva una pelliccia di plastica tigrata, le mani profumate di qualcosa. Ha riso con me, tutto il tempo e poi è andata via. Proprio come ieri, quando la figlia mi ha scritto che il giorno prima le ha chiesto di cercarmi, che voleva ringraziarmi di averla fatta ridere tanto, per dirmi che quel giorno e i giorni che sono venuti era stata felice.
Hai capito? Sai di cosa parlo?
Hai ragione, nulla che ti riguardi, cose che prudono il naso.
Che domanda è? Ho pregato fno ai sette anni. Poi silenzio, ché il tempo vale.
Ah questo è il punto.
Non guarderò le tue foto. Cosa vuoi che ne sappia io, di fotografia, della tua, se non conosco l’odore della tua infanzia, se non so il suono che ti fa il mondo, se non ho amato il tuo primo amore, visto la tua prima luce. È solo che nulla vale e vale tutto. Soprattutto l’invisibile.
No, no, vai a fanculo tu, i maestri, la condivisione, la pace interiore.
Mary Ann? Lei non ha chiesto, ha parlato.
Tanake? Apologia del Quotidiano.
Cosa vuoi che ne sappia di fotografia, fuori dalla mia.
(Gianluca Vassallo – Apologia del quotidiano)
Tanake è musica improvvisa, è cuore polmoni sudore (il cervello c’è ma si tiene nascosto), è musica mentalmente fisica, è musica fisicamente mentale, è il crepuscolo all’alba, il miele amaro, la fresca decomposizione, la gioia del pianto. Tanake è musica generata dai tre suoi spasimanti…
Nel primo disco (tsu.zu.ku|2000) tanake attraverso l’improvvisazione arriva alla costruzione di brani, di pezzi finiti; col tempo però l’attitudine si sposta con sempre maggiore determinazione negli spazi claustrofobici e infiniti dell’improvvisazione pura (reazioni pilomotorie|2004). melodia e cacofonia, gli opposti che si incontrano in dissonanze melodiche capaci di generare atmosfere rarefatte e rilassantemente ansiogene, strumenti percossi quasi a creare dolci melodie, talvolta accarezzati ruggiscono di dolore… trepidanti, cupidi dell’altrui timpano da violentare e cullare….
Ulteriore sviluppo di questo processo è 3ree, disco prodotto da nipa.prodz, ebria records e fratto9 under the sky records e distribuito sul territorio nazionale da jazz today.
Tanake ha suonato in festival, club, centri sociali, associazioni culturali e gallerie d’arte con ulan bator (fr), kaffe matthews (uk), ovo, zu, sinistri, damo suzuki’s network, anatrofobia, giuseppe ielasi, tasaday, vonneumann, tiziano tononi, uncode duello, with love, inferno e molti altri.
_
4tet, il quarto disco in studio firmato Tanake, vede la luce dopo varie vicissitudini, chi lo ha aspettato lungamente ne è consapevole!
Esce in vinile, 100 copie uniche, diverse per l’immagine di copertina.
Gianluca Vassallo aderisce al progetto con Apologia del quotidiano, un racconto fotografico intimo e influenzato dall’ascolto del disco che, a partire dal primo ottobre 2018 per 100 giorni, diventerà la copertina dell’album, ogni giorno diversa.
La stessa sarà pubblicata sul sito e sui social media dell’ensemble. Chi fosse interessato all’acquisto del vinile può scegliere la sua copertina preferita tra quelle disponibili, o se preferisce il numero progressivo da 1 a 100 copie, che verrà stampato in fine art grazie al prezioso contributo di Giuseppe Serra e del suo Artech Studio di Nuoro.
Al termine della campagna fotografica seguirà la mostra delle 100 copertine con un evento musicale di presentazione dell’album, da allora partirà l’invio delle copie prenotate.

4tet (Tanake) n.03 (03/10)

4tet (Tanake) n.15 (15/10)

4tet (Tanake) n.61 (30/11)

4tet (Tanake) n.18 (18/10)

4tet (Tanake) n.25 (25/10)

4tet (Tanake) n.53 (22/11)
Noi di Casa di Ringhiera abbiamo prenotato la nostra copia di 4tet.
La numero 53.
Abbiamo ascoltato i pezzi in anteprima (lo ammetto), ma non vediamo l’ora di avere la nostra copia. Fisica. Tra le mani. Perché un conto è ascoltare con gli auricolari la musica e un altro conto è lasciare che la musica spazi nell’aria da un vinile. Dico bene?
Io i Tanake li ho ascoltati dal vivo, una volta, anni fa. E mi sono innamorata di quei suoni. Ci sono viaggi dentro i loro suoni che non ti aspetteresti mai. Minuscole schegge di musica altissima che ti trascinano in un luogo altro, a volte in modo lento e suadente altre volte in modo improvviso che il cuore, be’ il cuore ti salta in gola. Pura semplice emozione, sempre.
Che poi, in fondo, è quello che ci si aspetta dalla musica. Che sia capace di emozionare. E la musica dei Tanake ci riesce, tipo, sempre.
Noi qualche domanda gliel’abbiamo dovuta fare, giusto per capire chi sono questi ragazzi. Dopodiché vi lasciamo alle loro atmosfere sonore. E alle vostre intime emozioni.
(Siete ancora in tempo per prenotare la vostra copia di 4tet, se leggete tutto l’articolo in fondo in fondo in fondo ci sono tutti i Link necessari).

Cosa significa il vostro nome, Tanake?
È una parola del vocabolario nuorese, ci piaceva la sua sonorità vagamente orientale, tanache è il picciuolo ovvero la struttura che sostiene e collega la foglia, o il frutto, al ramo. Per noi rappresenta il legame con la nostra terra d’origine.
Ho sentito che Tanake nasce dalle ceneri di un’altra band; quanto tempo è che suonate insieme e quanto è cambiata la vostra musica dagli inizi a oggi?
Suoniamo insieme dal 1994, ma solo dopo cinque anni siamo diventati quelli che siamo ora. La nostra musica si è sviluppata insieme a noi, è sempre stata lo specchio delle nostre sensazioni ed emozioni, il frutto dei nostri ascolti e delle nostre percezioni del quotidiano.
Musicalmente siamo partiti da strutture semplici con arrangiamenti via via sempre meno scontati fino a destrutturare tutto con sessioni di improvvisazione pura, utilizzando gli strumenti in maniera sempre meno ortodossa.
Le vostre sonorità non sono di facile ascolto per chi non è avvezzo alla Musica. Molta improvvisazione. Molta musica colta. In un mix di suoni che ti trasporta davvero lontano lontano.
Chi sono stati i vostri maestri, i musicisti che vi hanno ispirato?
Qualcuno ci definì emozionali, ma non ricordiamo chi…
Inizialmente l’improvvisazione ci portava a creare la musica, session infinite si trasformavano in tracce definite: pian piano abbiamo acquisito una consapevolezza che ci ha portato a limitarci alla sola improvvisazione eliminando completamente la struttura musicale, per creare dei pezzi finiti in base agli elementi sonori, ogni volta diversi, che ci scambiamo durante le sessioni, sia in studio sia dal vivo.
In realtà non crediamo che sia necessario avere una certa cultura musicale per apprezzarci, quanto riuscire a emozionarsi per le atmosfere che creiamo. Forse per apprezzarci veramente bisogna essere empatici e con il giusto grado di concentrazione. A volte, per favorire l’ascolto, usiamo proiettare un video, quasi fosse un film da musicare.
I nostri maestri sono molteplici, si va dal cantautorato al jazz più estremo degli anni ’60, dal post rock fine anni ’90 alla pura sperimentazione. Riusciamo a tradurre nel nostro linguaggio tutto ciò che vediamo e ascoltiamo, ciò che proviamo, in un susseguirsi di visioni e sonorità.
Com’è nata l’idea di quest’album e di farne 100 pezzi numerati con 100 copertine diverse. Un progetto lungo 100 giorni, certo anche molto di più.
So che siete tutti e tre amanti della fotografia, ognuno di voi in modo diverso. Ma in che modo queste 100 fotografie sono correlate con 4tet?
Questo album nasce otto anni fa, nella provincia pisana dove ci siamo rifugiati tre giorni e per tre giorni abbiamo suonato e inciso in presa diretta e in totale improvvisazione. Purtroppo i fatti della vita ci hanno separato geograficamente e siamo riusciti a riprendere il progetto solo da un anno. L’album non vuole essere un ultimo lascito ma un punto importante della nostra maturità artistica, e pertanto bisognava necessariamente creare qualcosa di unico e forte che non fosse la sola musica ma che potesse raccontarci in modo più completo.
Per fare questo avevamo bisogno di un ulteriore contributo, un occhio di chi è parte del progetto 4tet come uno strumento aggiunto che racconta un’ulteriore visione non più e non solo musicale. Gianluca Vassallo ha subito sposato la causa con un preziosissimo lavoro che traduce in immagini la nostra musica, influenzato non dalle nostre emozioni ma da quelle che la nostra musica gli trasmette. Il lavoro fatto fino a qui è straordinario, siamo molto soddisfatti e non vediamo l’ora di vedere stampate tutte le 100 copie.




Sono copertine, quelle realizzate da Gianluca Vassallo, che sembra raccontino in modo discreto la vostra terra di origine.
Quanto c’è della vostra isola nella vostra musica e in quest’album in particolare?
In realtà raccontano del quotidiano, in modo sistematico e a tratti ossessivo. Molti degli scatti sono stati fatti oltre tirreno, non c’è e non vuole esserci un vincolo territoriale ma solo continuità narrativa fra immagine e libera interpretazione della musica. In un preciso momento, in un preciso contesto in cui accade qualcosa.
Noi tre siamo nati e cresciuti in un’isola e questo ha, volenti o nolenti, forgiato il nostro approccio alla vita e il nostro carattere, ma le influenze che poi traduciamo in suono sono comunque molteplici, il nostro modo di mettere in musica le nostre emozioni è viziato dalle nostre letture e dai nostri ascolti, dai paesaggi quotidianamente vissuti, dai contrasti della terra stessa.
Questo progetto si discosta dai precedenti. Una scelta di raggiunta maturità artistica oppure il volere creare un oggetto (d’arte) in quest’epoca dove la musica è quasi del tutto scomparsa dai supporti fisici?
Il nostro sogno è sempre stato quello di poter licenziare un vinile, veniamo da un’altra generazione, siamo feticisti e abbiamo sempre cercato di curare il packaging e i layout dei nostri lavori. Da amanti, tutti e tre, della fotografia, già nell’album “reazioni pilomotorie” avevamo inserito una polaroid diversa in ogni cofanetto. Il legame tra fotografia e musica lo abbiamo sempre assecondato e sviluppato.
Vi ho visto in concerto, una volta sola, nella primavera del 2001 al CPA di Firenze. Mi piacerebbe riascoltarvi dal vivo. Quando sarà possibile?
L’idea è quella di riuscire a fare un mini tour nella penisola nella primavera del 2019 toccando le città che hanno un significato per noi: Firenze perché è lì che siamo nati e cresciuti artisticamente; Milano perché nei nostri ricordi è il miglior posto dove abbiamo suonato e dove poter suonare; Roma perché un sacco di amici ci aspettano!
In ogni caso per il 26 gennaio è prevista la presentazione del progetto a Nuoro (dove siamo nati) presso il garage33, dove verranno esposte le 100 copertine e, a distanza di nove anni dall’ultima volta presenteremo un nuovo set dal vivo.
Adoro molti dei vostri titoli tanto quanto i vostri pezzi, ma da dove nasce l’idea dei titoli? (Solo una curiosità)
– La contessa abbandona le gare.
– utilità sociale intesa come interesse della collettività alla manifestazione del pensiero
– could your brain be more reflective than a mirror
– sick music makes healthy dancers
– il mio autismo musicale (una discreta espressione del nulla)
I titoli offrono un ulteriore livello interpretativo dei pezzi, quasi fosse il testo per i nostri brani esclusivamente strumentali. In questo Roberto è un abilissimo e visionario compositore.
Coi titoli si gioca ad ampliare lo sfondo immaginario che la musica crea (o vuole creare), il titolo nel caso nostro è l’appendice della fase creativa… a volte è suggerito dalla musica stessa, altre era già li che l’aspettava appuntato in un quaderno…
L’ironia senza dubbio è elemento fondante dei tanake… e quasi sempre è legata al tragico… spesso prende toni comici, benché probabilmente poco palesi, ma sempre su un fondo cupo o melancolico…. tutto questo fluisce con naturalezza, non ci sono forzature.
Per soddisfare la tua curiosità relativamente ai titoli elencati:
– La contessa abbandona le gare
È ispirato a Maria Teresa de Filippis, prima donna pilota di una Formula 1 di altre epoche, che abbandona le gare al suo primo anno in Formula 1 dopo che in quella stagione muore l’ennesimo collega-amico in pista
“Amici con i quali avevo macinato chilometri […], vivendo insieme tra Europa e Sud America circondata dal loro affetto, spesso vittima dei loro scherzi, l’amica vera, la piccola da proteggere, il pilotino pieno di gioia di vivere e d’allegria. Non avrei più saputo ridere come prima senza di loro ed è finita così, con l’addio alle corse”
– utilità sociale intesa come interesse della collettività alla manifestazione del pensiero
È quella che ebbe l’affermazione di Piero Ricca quando osò dare del buffone all’allora premier Silvio Berlusconi nel palazzo di giustizia di Milano (sentenza 19509 della quinta sezione della Cassazione)… con nostra massima approvazione
– could your brain be more reflective than a mirror
Una visione in sala prove, una vecchia cascina con una bizzarra credenza curva e rivestita da strisce di specchi riflettenti porzioni di realtà fatta a pezzi… (da qualche parte abbiamo ancora la foto)
– sick music makes healthy dancers
Difficile vedere ballare qualcuno ai nostri concerti, ma talvolta accade… e quelli devono essere proprio sani!
– il mio autismo musicale (una discreta espressione del nulla)
L’approccio a suonare per bisogno porta a esplorarsi dentro e a non curarsi (apparentemente) del contesto, mostrando un paradossale effetto autistico ed empatico, che di per sé parrebbe un ossimoro ma che tale non è.
Una definizione per questo album, sotto quale genere possiamo includerlo?
Non amando i generi e le etichette, così come i confini e le bandiere, ma comprendendo che se ne deve parlare in qualche modo bisogna avere modo di raccontarlo… magari come farebbe un sommelier per il vino andrebbe bene… decidete voi
free form rock – jazz core
Musicista (o band) preferito/a?
Martino – Nick Cave
Maurizio – Nick Cave
Roberto – June of 44
Canzone preferita?
Martino – Of information & belief – June of 44
Maurizio – The anarchist’s anthem – 4 walls
Roberto – Didn’t We Deserve A Look At You The Way You Really Are – Shellac
Concertone preferito?
Martino – Nick Cave and the bad seeds – Barcelona Forum – 21/05/2015
Maurizio – Nick Cave and the bad seeds – Arezzo Wave – 06/07/2001 (folgorante!)
Roberto – Sonic Youth – Museo Pecci – 08/07/1993 (ha aperto nuovi mondi)
t a n a k e
MartinoAcciaro DrumsTypewriterNoise
MaurizioBosa BassDoubleBass AmFmwaves
RobertoAcciaro GuitarTromboneAmFmWaves
http://www.tanake.net
https://www.facebook.com/tanakeensemble/
https://www.instagram.com/tanakeensemble/