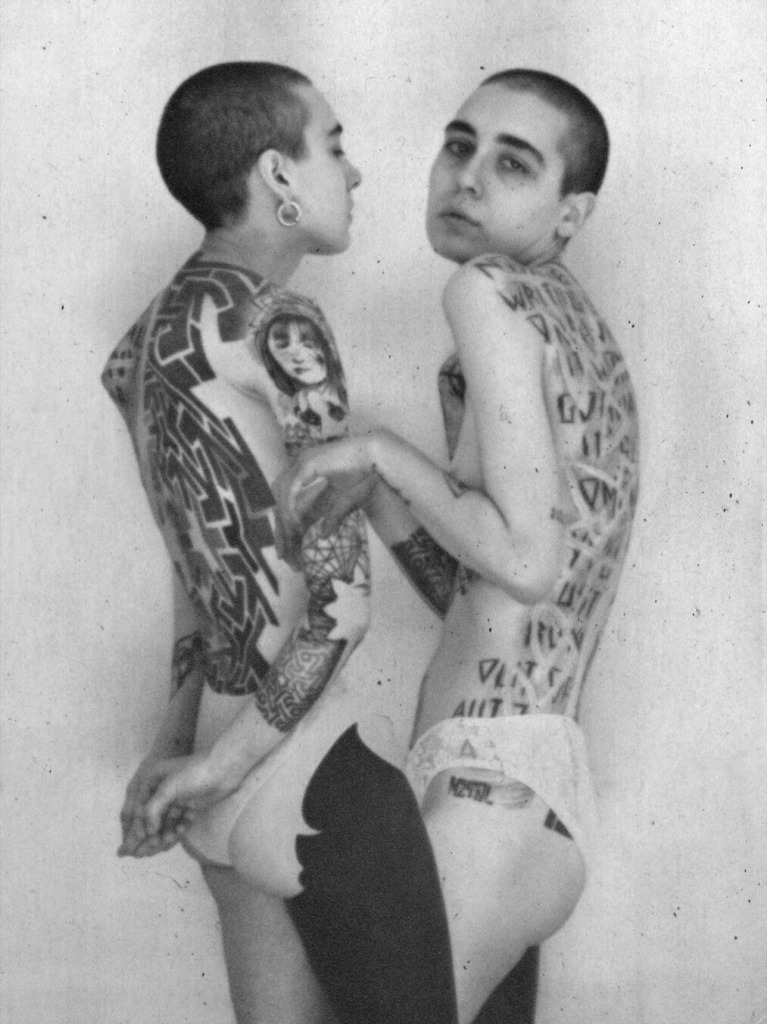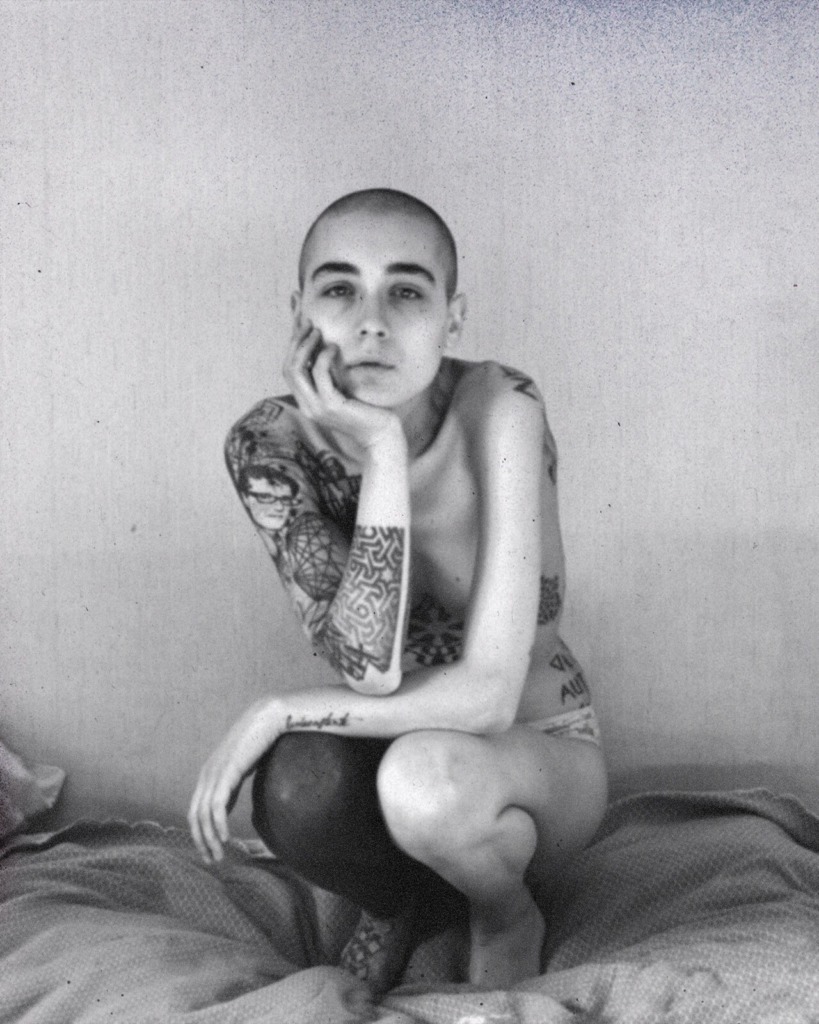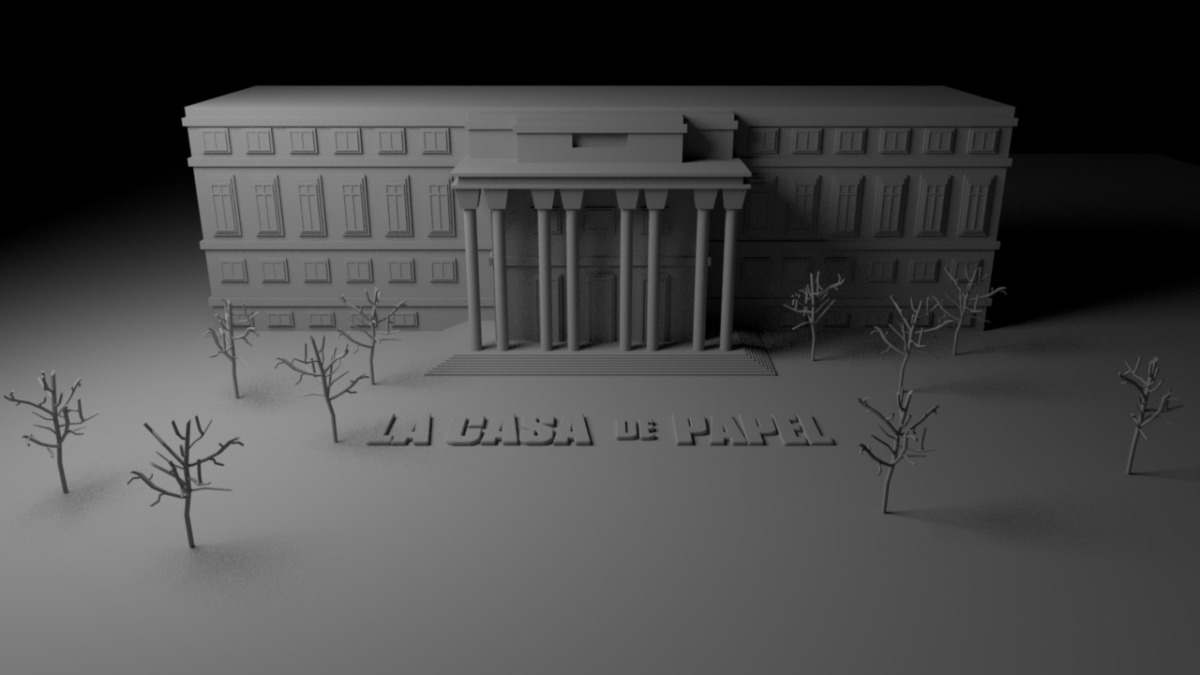“Quando un pensiero ti domina lo ritrovi espresso dappertutto, lo annusi perfino nel vento”
Avevo scritto questa frase sulla mia Smemoranda, ai tempi del liceo, come si usava fare con le belle citazioni. Adolescenti presi dagli amori non corrisposti, dalle baruffe con gli amici, dai rapporti in fieri con i genitori. Ognuno convinto di avere il futuro in ginocchio davanti a infinite possibilità, egotismo ingenuo allo stato puro. Tutto ruotava intorno a noi, o così credevamo. Chiusi nelle nostre camerette e tutto il mondo fuori. E quei pensieri fissi che non davano pace.
Così, anche se leggo, mi sembra di ritrovare tracce virulente tra le righe. Ma non solo, ché l’adolescenza è finita da un pezzo e ho accumulato altro, vivendo.
Non posso scrivere una recensione: Il Libro dell’Inquietudine di Fernando Pessoa diventa un diario, diventa il mio specchio e mi scava dentro.
Sarà per questo che mi è tornata in mente la citazione di Thomas Mann, chiusa come sono nel mio appartamento e tutto il mondo – devastato – fuori. E pochi pensieri che fiuto ovunque, perfino nel vento triste che fa fatica ad entrare dalle finestre.
Ecco perché dirò soltanto la mia, dal mio punto di vista, limitato da queste quattro mura e lo farò con sentimento.
Altrove, senza dubbio, esistono i tramonti. Ma perfino da questo quarto piano sulla città si può pensare all’Infinito.
È un caso che mi sia trovata tra le mani il romanzo-non romanzo di Pessoa proprio in questo momento indescrivibile di vita reclusa. Per la verità, avevo intrapreso la lettura in tempi non sospetti, o poco sospetti, per poi concedermi una pausa, perché non è un testo semplice, anzi è veramente impegnativo (valga come invito, però, perché se ce l’ho fatta io…)
Ecco, nel caso decideste di attraversare adesso le pagine frammentate di Pessoa non verreste assolutamente catturati da questo Infinito guardato/pensato da una finestra? Io abito perfino al quarto piano…
E così subentra l’Identificazione. Apriamo questo capitolo, che è poi la ragione per cui mi trovo qui, davanti alla quinta parete di casa mia, lo schermo del computer.
Vi sarà capitato di leggere qualcosa e di pensare “Cavolo – ognuno scelga l’esclamazione che gli è più congeniale – ma avrei potuto scriverlo io!”; certo, se tutti fossimo capaci di dare forma al caos vorticoso delle nostre teste. E va bene, ammesso che io fossi stata in grado di scrivere una grande opera, avrei scelto proprio questo modo e queste stesse parole: frammenti.
Frammenti, i suoi, da ripercorrere più e più volte per assicurarmi di aver compreso o, perlomeno, di essermi avvicinata al senso.
E si ha l’impressione che quell’Infinito Pessoa, o il suo eteronimo Bernardo Soaeres, ce lo abbia dentro.
Che cosa c’è da confessare che valga la pena o che sia utile? Quello che è successo a noi, o è successo a tutti o esclusivamente a noi; nel primo caso non è una novità e nel secondo caso non è una cosa che si possa capire. Se scrivo ciò che sento è perché così facendo abbasso la febbre del sentire. Quello che confesso non ha importanza perché niente ha importanza.
Con ciò che sento costruisco dei paesaggi. Fabbrico delle vacanze con le sensazioni. Mi è facile capire le ricamatrici che ricamano per pena e coloro che fanno la calza perché esiste la vita. La mia vecchia zia faceva dei solitari durante l’infinito delle sere di veglia. Queste confessioni del sentire sono i miei solitari. Non li interpreto come chi interroga le carte per conoscere il destino. Non le scruto perché nei solitari le carte non hanno un valore preciso. Mi srotolo come una matassa multicolore oppure invento con me stesso delle figure di spago come quelle che fra bambini si tessono con le dita aperte e si passano da un bambino all’altro. L’unica cosa che mi sta a cuore è che il pollice non sbagli il laccio che gli spetta. Poi giro la mano, l’immagine cambia ed io ricomincio.
È tutto un sentire in solitaria.
Non ci si aspetti che in questo romanzo accada qualcosa, perché, a parte il sapere che il protagonista sia un contabile, di concreto c’è ben poco.
Sì, certo, c’è Lisbona e c’è Rua dos Douradores, dove ha sede l’ufficio in cui il protagonista lavora:
Penso a volte che non uscirò mai da questa Rua dos Douradores. E se lo scrivo, mi sembra l’eternità
Ma potrebbero essere una città qualsiasi e una strada qualsiasi, ovunque, perché il paesaggio intorno diventa paesaggio interiore, e viceversa.
Così, la Baixa diventa il mio quartiere, nella mia città. Dentro di me.
Ed io esco. Uscivo, prima di ogni decreto, prima che il mondo fosse avvelenato – già mi sembra un’eternità.
Ho passeggiato tante volte lungo le strade gremite di gente, solo per camminare, solo per osservare gli altri. Come se essere circondata dal resto dell’umanità mi offrisse l’occasione per allontanarmene. Come se facendo indigestione della vita altrui potessi ritornare alla mia. Cercare il mio posto nel fluire del mondo, tirandomene fuori.
Però Soares è un nichilista e, qualsiasi cosa voglia dire, io non lo sono.
Pessoa, autore schizofrenico che cede la penna a diversi eteronimi, dice del protagonista del Libro che in realtà è “una mutilazione della mia personalità: sono io senza il raziocinio e l’affettività”. Prendiamo le distanze dal nichilista assoluto.
Il contabile inquieto non ha amici, non ha amanti, non ha famiglia e non ne sente il bisogno. È completamente e inevitabilmente solo con se stesso e i suoi sogni. Con se stesso e le sue riflessioni, con se stesso e le sue visioni, con se stesso e una stanchezza di tutto. Il mondo di Bernardo è tutto interiore eppure terribilmente esteriore. Guarda di continuo fuori dalla finestra del suo ufficio o da quella della sua camera d’albergo, ove trascorre notti insonni. Cercando il sogno, in cui tutto è possibile. O aspettando l’alba che lo liberi dall’abisso di se stesso.
Io non ho il buio nell’anima ed ho amici, amori, una famiglia (ok, ora siamo tutti un po’ più soli e guardiamo parecchio dalla finestra).
Eppure se guardo bene dentro di me scorgo zone d’ombra. E chi, del resto, non ha angoli nascosti nel profondo, in cui la luce stenta ad arrivare? Se quindi la sovrapposizione del mio Io non può essere totale a quella del Narratore che si confessa, tra le sue parole sparse ne raccolgo molte e quelle trovano corrispondenza perfetta con i miei segreti inviolabili e imperscrutabili.
I suoi occhi diventano i miei, nello sguardo asettico e partecipe – gli ossimori sono naturali nel caos lucido dell’Inquietudine.
Il silenzio che scaturisce dal rumore della pioggia si diffonde in un crescendo di grigia monotonia lungo la strada stretta che io fisso. […] E non so quello che sento, non so quello che voglio sentire, non so quello che penso né quello che sono.
Chi può dire se leggere Pessoa in altri momenti della mia vita mi avrebbe fatto un effetto diverso. Oggi di sicuro non sono quella di ieri e non sono quella di domani – ovviamente, anche questo si troverà scritto per mano di Soares. I libri ci vengono incontro quando ne abbiamo bisogno. Non per salvarci, ché io non ci ho mai creduto alla storia che “la Bellezza salverà il mondo”: provateci a barattare le Lacrime con la Bellezza, è proprio tutta un’altra faccenda.
Di sicuro c’è un momento giusto per gli incontri e questo per me era il momento di Pessoa. Ho lasciato scivolare l’inquietudine di un altro sui miei paesaggi interiori. Come nebbia, come pioggia, come vento. C’è così tanto, forse tutto – di sicuro troppo – in questi frammenti, che non sono riuscita ad averne una visione di insieme. Le lunghe ore interminabili di questo che, ormai, tutti chiamiamo Tempo Sospeso hanno fatto a pezzi la nostra anima, che credevamo immensa e indistruttibile, come fossimo ancora adolescenti non cresciuti abbastanza.
Se ne esce un po’ spossati da questo viaggio, lo ammetto, ma cavolo – di nuovo a ognuno la sua esclamazione – se ne vale la pena!
In questo momento ho così tanti pensieri fondamentali, tante cose veramente metafisiche da dire, che mi stanco all’improvviso e decido di non scrivere più, di non pensare più, e di lasciare che la febbre di dire mi dia sonno, e io accarezzi, come si accarezza un gatto, tutto quanto potrei aver detto.