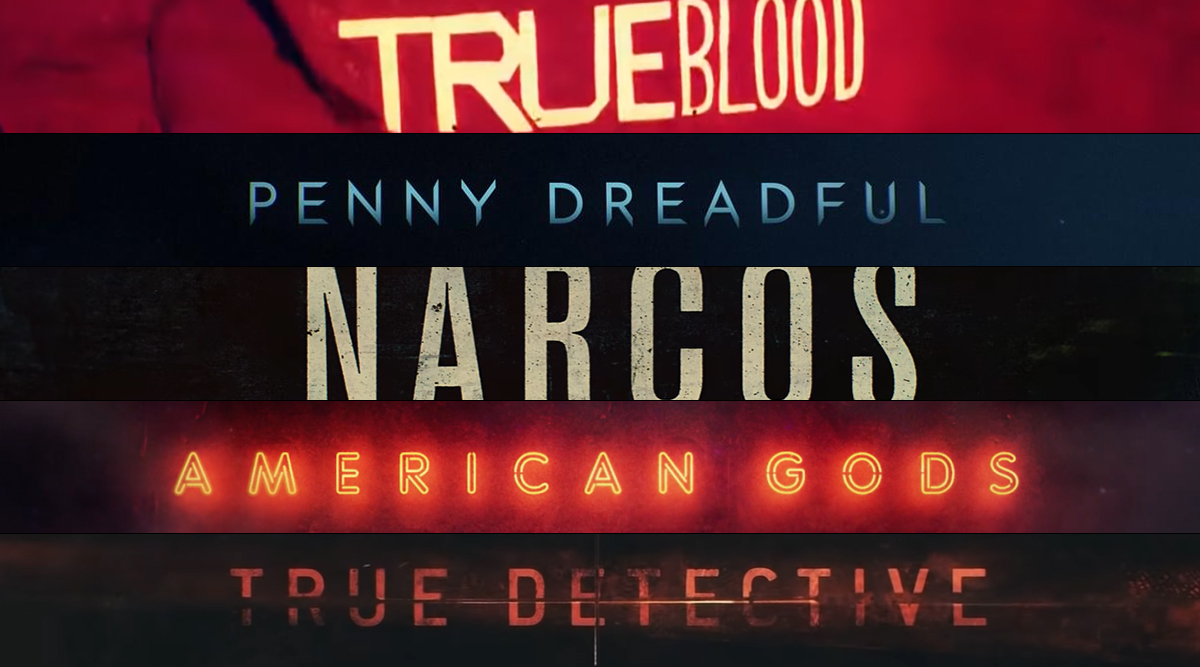Distillare un’intera stagione di temi, storie e idee in una sequenza molto breve. È tutta lì la magia di una sigla. Ce ne sono di memorabili, di premiate, di osannate. C’è chi le adora e chi le skippa. Le cinque di questo articolo non sono le migliori in assoluto nell’olimpo delle sigle tv. Ma hanno quel qualcosa che invoglia a saperne di più, a scoprire cosa c’è dopo.
Iniziamo con True Blood.
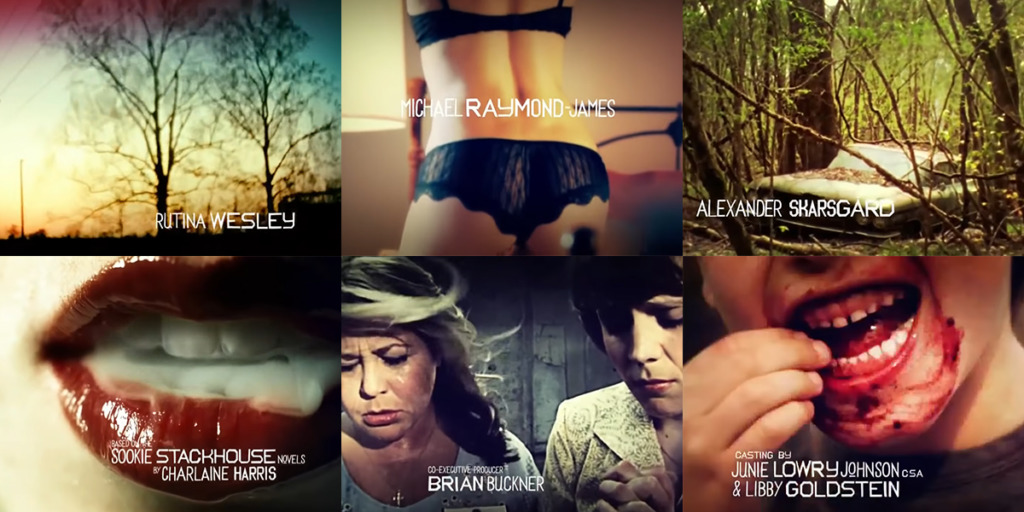
Il team della Digital Kitchen, studio di produzione creatore anche degli opening credits di Six Feet Under e Dexter, scelse la canzone di Jace Everett, “Bad things”, e viaggiò proprio in Louisiana per effettuare le riprese per la sigla di True Blood. Quello che spunta infatti, nei suoi primi fotogrammi, è una chiarissima ambientazione umida e paludosa da profondo sud degli Stati Uniti. E appaiono lampanti due tematiche fortemente presenti nell’intera serie: fanatismo religioso ed energia sessuale. Il tutto tenuto insieme dalla costante presenza della morte.
Estremismo esplicito. Immagini di decomposizione. Un degradato bar di quartiere in cui donne e uomini flirtano senza pudore. Uomini in vesti da Ku Klux Klan, vecchie auto abbandonate nei pantani dei bayou. C’è religione e tutto ciò che va contro la religione. E la sigla rappresenta perfettamente questa lotta, sia attraverso le immagini che il montaggio: fotogrammi velocizzati o rallentati ah hoc, alternati da flash di corpi nudi e contorti che lampeggiano in modo talmente rapido che quasi ce li si perde, fotogrammi che si increspano e gorgogliano come pezzi di rullini rovinati.
La perfetta metafora degli impulsi, sessuali e sanguinari, degli abitanti di Bon Temps. I peccati che nascondono nell’ombra. Tutte le “bad things” di cui canticchia Jace Everett. La sigla di True Blood è un’allegoria: una nuda lussuria dipinta come bancarotta morale di fronte alla fervente preghiera che appare in tutta la sequenza. Il bigottismo e la discriminazione contro la presenza di Dio. Perché Dio c’è eccome, ma c’è anche l’odio. E forse in misura maggiore.
Persino le tecniche scelte per le riprese contribuiscono a enfatizzare la forza presente nella sigla: trasferimento Polaroid, caratteri tipografici ispirati alla segnaletica stradale degli stati del sud, fotogrammi tagliati di netto, per dare sensazione di nervosismo, o sporcati da goccioline di sangue. E i colori: fangosi, lomografici, con forti dominanti di verde salvia, rosso sangue e nero fumoso.
Ci ho sempre visto del Tarantino in questa sigla. E qualcosa di Harmony Korine e David Lynch.
Molto simile, per scelta delle immagini rappresentative, è la sigla di Penny Dreadful.

E no, la serie non prende ispirazione da un personaggio con quel nome ma dai “penny dreadful”, popolari pubblicazioni diffuse nel XIX secolo nel Regno Unito, che raccontavano dozzinali storie dell’orrore per la classe povera del paese. Costavano un penny e, nonostante fossero caratterizzati dalla scarsa qualità sia di forma che di sostanza, a loro dobbiamo il merito di aver spianato la strada al romanzo horror gotico e a molti dei luoghi comuni di cui pullula tuttora la letteratura sui vampiri.
Gli opening credits di Penny Dreadful sono il perfetto riassunto di questo genere gotico vittoriano ma non hanno nulla di dozzinale. A partire dalla colonna sonora di Abel Korzeniowski, maestosa e lirica nel suo crescendo. È grazie ad essa che il pubblico riesce a sopportare immagini da incubo e fioriture insanguinate. La musica classica come sinonimo d’intellettualismo nobile che trascina lo spettatore nel macabro, nel livore, creando una sorta di morbosa attesa da cui ci si vorrebbe allontanare ma no, non si può, non senza guardare fino alla fine.
I soggetti, ragni, serpenti, crocifissi, e qui la similitudine con True Blood, simboli religiosi contro brutalità animale e peccato, sono ripresi in modo talmente ravvicinato da anestetizzare quasi lo sguardo, in una voluta intenzione di ammansire la paura di chi guarda. L’illuminazione cupa, inoltre, gioca a favore della sensazione onnipresente di malvagità ed enigma che percorre tutta la serie.
C’è del gore grottesco. C’è il nero, il blu notte, il rosso del sangue di una tazzina stracolma. E poi c’è il viso candido della protagonista, Vanessa Ives. Il focus è su di lei, sui suoi demoni interiori.
I secondi finali della sigla, un nugolo di pipistrelli che, eccezionalmente, vediamo volare verso il sole, fanno sorgere una domanda spontanea: questi personaggi tormentati riusciranno a salvarsi dalle tenebre e saranno meritevoli di redenzione e amore alla fine?
Completamente diversa in tematiche, stile e contenuti, ma sempre firmata dalla Digital Kitchen, è la famosissima e osannata sigla di Narcos.

Avevo letto da qualche parte che non ci si poteva definire dei veri fan della serie se la si saltava. Certo è che la canzone “Tuyo” di Rodrigo Amarante ha fatto battere più di un cuore.
La prima e la seconda stagione di Narcos hanno una sequenza di immagini identiche, sulla quale la DK e Nick Kleverov, direttore della fotografia, hanno tessuto i fotogrammi in modo che dessero l’aria di appartenere ad un filmato dell’epoca. Doveva sembrare un diario, un quaderno intimo, confondere le acque tra quello che è stato effettivamente estrapolato da veri video e foto d’archivio e quello che è stato filmato ad hoc per la sigla.
Quello che accade è una separazione dei livelli, quasi come se fosse un proiettore per diapositive a trasmettere le immagini: persone in aereo con i visi oscurati, in stile “video di sorveglianza”, Miss Colombia a Santa Monica con francobolli di Bogotà, delle labbra, simbolo del fascino e dei vantaggi che provengono dal vivere quella vita, l’Hacienda Nápoles dove visse Pablo, chiaramente un filmato originale ma enfatizzato nella velocità e nel movimento per dare l’illusione di essere ripreso proprio in quel momento. E poi la scena del vero omicidio, lo schiaffo che fa tornare alla realtà, alla crudeltà del protagonista che, finora era stato tutto coca, armi e valigette di soldi, ma che inizia a mostrare il rovescio della medaglia.
Una metafora della strada verso la distruzione di un mondo che, da principio appare come irresistibile, ma che alla fine si rivela sadico e masochista. Però, che dire? Tutto è addolcito e reso accettabile dalla canzone di Amarante. Indimenticabile.
E veniamo al quarto titolo di testa. È la magnifica sigla di American Gods, serie che mette in scena l’omonimo romanzo fantasy di Neil Gaiman.

Si deduce facilmente che il tema principale sono gli dei e, nello specifico, la lotta tra antichi e nuovi e quello che essi rappresentano: il vecchio e il nuovo, la tradizione e l’innovazione, la devozione e la tecnologia.
Gli antichi dei li conosciamo. E i nuovi? Internet, i social media, l’industrializzazione, la droga, le armi, l’inquinamento. Anche qui, una metafora.
Sulle note tribal-techno della canzone di Brian Reitzell, va in scena uno spettacolo psichedelico di demoni e divinità che si mescolano tra simbolismi e iconografia moderna e antica, tinta di neon, di verde chartreuse, fucsia, azzurro e cremisi.
L’autore di questo marasma visuale è Patrick Claire, creatore di sigle per True Detective, Westworld e The Night Manager. Uno che se ne intende, insomma. È così che sullo schermo ci appaiono diversi fotogrammi, veloci ma densissimi di significato: l’albero vichingo della vita, riferimento piuttosto sottile alla vera identità di Mr. Wednesday; una testa capovolta della gorgone Medusa, i cui serpenti vengono sostituiti da cavi di fibra ottica; tre ninfe che al posto degli occhi hanno un obiettivo, chiara allusione alla moderna ossessione della gente per gli autoscatti.
Una Madonna, celata da un velo, non di seta, ma di tecnologia realizzata da fili di silicio, l’ennesima metafora della religione tradizionale “oscurata” dal nuovo dogma; e poi il Buddha, strafatto di droga, l’antitesi della medicina orientale contro quella occidentale, e Ganesh, la divinità indiana per eccellenza, il “Distruttore degli ostacoli”. Nella sequenza compare sornione, seduto su un fiore di loto circondato da siringhe e tubi. È sottile il rimando alla fecondazione artificiale. L’evidenza schiacciante che Ganesh sia occupato a controllare gli smartphone che ha in mano dichiara la sconfitta della preghiera a favore della ricerca all’avanguardia per la risoluzione di un problema.
Quasi in chiusura, appare un cowboy in neon con una protesi al posto della gamba. Eccolo, il fallimento del sogno americano, che finisce che per avere come cavallo un centauro meccanico con una parabola satellitare invece del collo e la faccia di una bambola gonfiabile, e un astronauta crocifisso, teorica concezione della divinità classica venuta al mondo per salvarci e di un essere terreno che lascia la terra alla conquista dello spazio. L’uomo che conquista il cielo, che conquista Dio.
Infine, in cima al totem, l’aquila. Il Simbolo. Gli Stati Uniti d’America. Gli indiani d’America. Zeus. L’impero romano. Il nazismo. Un caos incasinato di religioni, credenze, messo insieme in modo sexy, appiccicoso e sporco. In pieno stile American Gods.
Della stessa direzione creativa, quella di Patrick Claire, è la sigla della prima stagione di True Detective, vincitrice dell’Outstanding Main Title Design Emmy nel 2014.

La visione per la sua realizzazione fu chiara fin da subito: descrivere il contesto geografico in cui è ambientata la serie, la Louisiana degli anni ‘90, territorio fortemente violentato dalla presenza di infrastrutture petrolchimiche e inquinamento del paesaggio, attraverso la divisione e lo spaesamento interiore dei protagonisti. E viceversa.
Per rendere attuabile questa ambiziosa idea, l’unica scelta stilisticamente e graficamente possibile fu l’uso della doppia esposizione, insieme alla post-produzione dei colori con Photoshop e all’aggiunta di forme vettoriali tramite Illustrator. Il risultato, trasportato dalle note della canzone “Far from any road” del gruppo The Handsome Family, è una frammentazione fisica e psicologica delle figure umane protagoniste della serie, usate come finestre attraverso le quali si intravedono paesaggi quasi apocalittici, fabbriche, discariche, fiumi inquinati, tralicci, pompe di benzina, raffinerie. Una traslazione del personaggio nella location e della location dell’animo del personaggio.
Gli stessi colori scelti danno la sensazione di sporco, di sotterrato: giallo pallido, verde, blu scuro, inceneriti e bruciacchiati. E sono proprio il fuoco e la cenere alcuni degli elementi chiave dello spettacolo: nei tagli finali, infatti, il fuoco svolge un ruolo sia costruttivo, ai fini della creazione della sequenza, sia distruttivo nello spingere la stessa verso il suo climax.
Come in true Blood, e ci torniamo per chiudere il cerchio, anche in True Detective si rende presente, anche se in maniera meno sfacciata, l’uso dell’iconografia cristiana: la connessione tra vizio e ambito religioso, enfatizzato dalla presenza nella sigla di forme femminili, di nudità e sensualità, in contrapposizione con la durezza delle forme di una croce o del moralismo imperante di quegli anni, rimanda ad un moralismo forzato e ambiguo che condurrà i suoi abitanti verso l’abuso, la criminalità e l’omicidio.
Come premetteva l’articolo in apertura, queste cinque sigle tv non vogliono ergersi a migliori in assoluto. Sarebbe una partita persa in partenza, perché molto soggettiva. Hanno però molto in comune tra di loro: fervenza religiosa, bigottismo, perversione, confini emotivi, lotte interiori, sessualità esplicita. Ogni titolo li interpreta a modo proprio, perfetta condensazione in pochi secondi di tutte le loro sfumature. Che possano piacere o no è legittimo.
Quello che è indubbio è che non possono lasciare indifferenti.
Editing immagini: Deborah D’Addetta